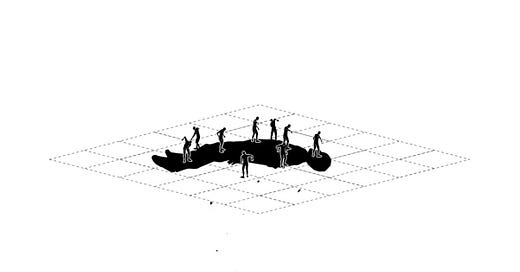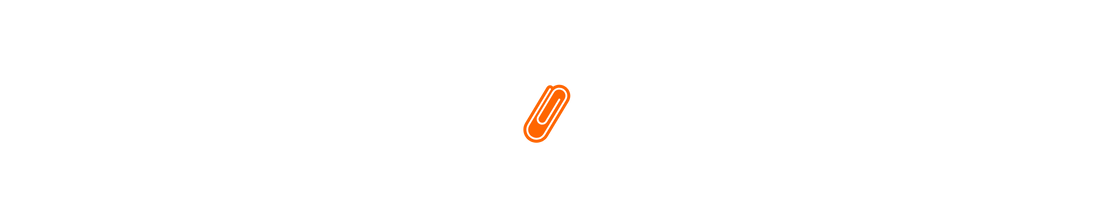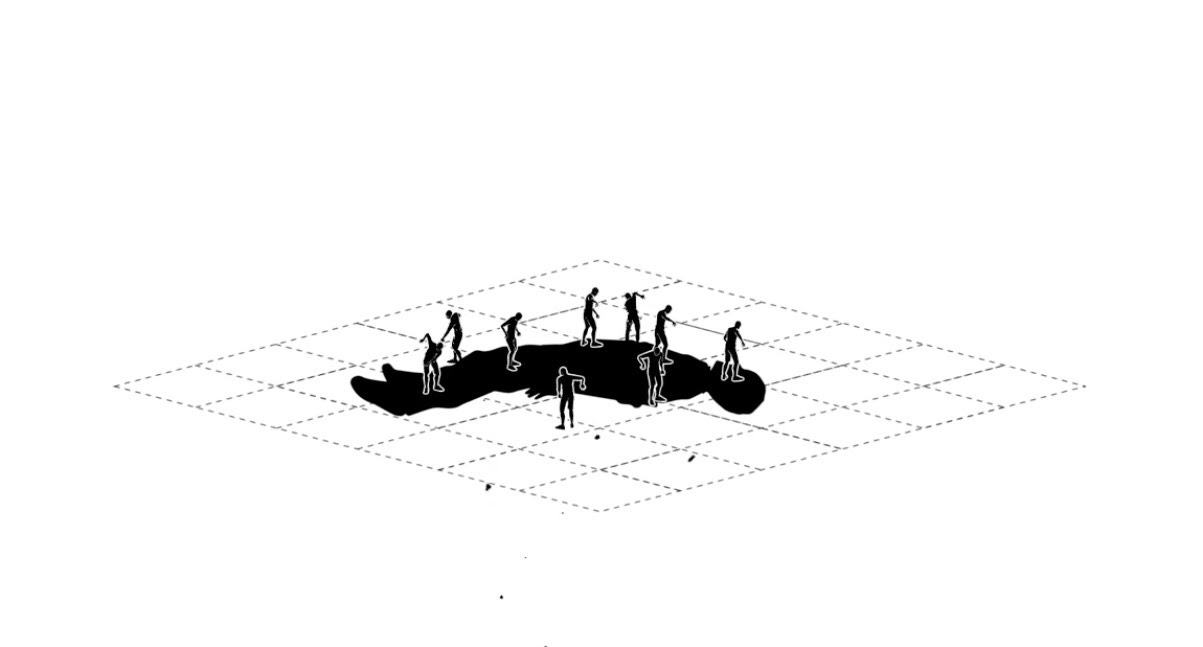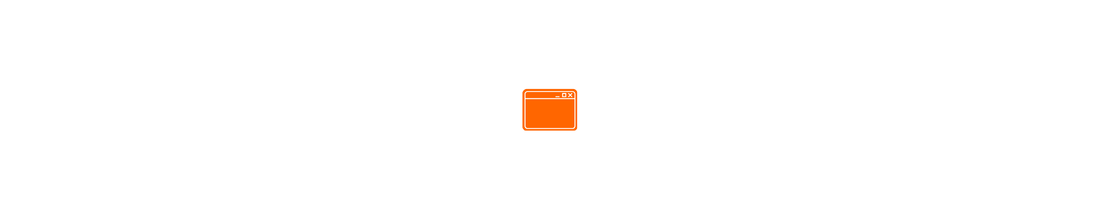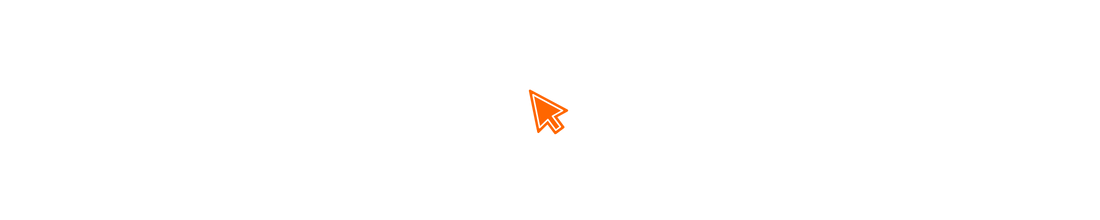Questa è chissenefrega: la newsletter su creatività, cultura e digitale di cui potrebbe non fregarti niente. O forse si.
Questa settimana mi sono ritrovata a pensare alla curiosità — ecco una puntata all’intersezione tra psicologia e neuroscienze per approfondire da dove arriva e se è davvero tutta uguale. Buona lettura!
Sulla curiosità
Nel 1839, un giovane Alexandre Edmond Becquerel, sperimentava con l’elettricità nel laboratorio di suo padre. Era appassionato di fenomeni di magnetismo, elettricità e ottica, che gli scienziati avevano appena iniziato a comprendere. Notò un fenomeno strano: una cella elettrolitica generava più energia quando era esposta alla luce solare. Lo chiamò effetto fotovoltaico.
Dovettero passare quarant’anni prima che altri due scienziati, William Grylls Adams e Richard Evans Day, scoprissero l’effetto fotovoltaico in una sostanza solida. Poi, nel 1905, Albert Einstein spiegò la fisica fondamentale alla base di questo fenomeno, dando il via alla rivoluzione quantistica nella fisica. Eppure, anche otto anni dopo, grandi fisici come Max Planck consideravano questa spiegazione assurda. A causa della mancanza di applicazioni pratiche apparenti, tutte queste scoperte non furono sviluppate fino a quando, negli anni ’50, un’azienda statunitense, la Bell Labs, realizzò la prima cella solare veramente utile. Il resto è storia.
Becquerel non era alla ricerca di nuove fonti di energia. Einstein non aveva idea che il fenomeno da lui spiegato avrebbe avuto implicazioni straordinarie per la produzione di energia. Oggi, tuttavia, possiamo beneficiare di decenni di contributi fondamentali alla ricerca di base, dove i ricercatori, mossi dalla curiosità, hanno perseguito quella che considerano la loro missione più stimolante: cercare di comprendere meglio il mondo in cui viviamo.
Ma quindi, cos’è la curiosità?
La curiosità è, a livello collettivo, uno dei grandi motori della scienza e della conoscenza, e a livello individuale un potente fattore di sviluppo e di salute mentale.
Anche se tutti sappiamo, o pensiamo di sapere, che cos’è la curiosità, Daniel Berlyne fu uno dei primi psicologi a proporre negli anni ‘50 un modello completo della curiosità. Sosteneva che tutti cerchiamo il punto di equilibrio tra due stati profondamente scomodi: la sotto-stimolazione (affrontare compiti, persone o situazioni privi di sufficiente novità, complessità, incertezza o conflitto) e la sovra-stimolazione. A tal fine, utilizziamo quella che Berlyne chiamava “curiosità diversiva” (come quando una persona annoiata cerca qualcosa—qualsiasi cosa—per aumentare la stimolazione) o quella che chiamava “curiosità specifica” (come quando una persona iperstimolata cerca di capire cosa sta accadendo per ridurre l’eccitazione a un livello più gestibile).
Basandosi sulle intuizioni di Berlyne, nel 1994 George Loewenstein, della Carnegie Mellon University, propose la teoria del “gap informativo”: le persone diventano curiose quando si rendono conto di non possedere una conoscenza desiderata; ciò genera una sensazione spiacevole di incertezza, che le spinge a colmare questa lacuna informativa.
Tuttavia, queste teorie non spiegano altre manifestazioni della curiosità: passeggiare in un museo, cercare di capire perché un progetto è andato bene o meno , immergersi nella lettura di un nuovo libro.
Così negli anni '70, Edward Deci, dell'Università di Rochester, analizzò queste questioni , sostenendo che la curiosità riflette anche la nostra motivazione intrinseca “a cercare novità e sfide, ad ampliare ed esercitare le proprie capacità, a esplorare e ad apprendere.” La utilizziamo non solo per evitare il disagio, ma anche per generare esperienze positive.
In un altro filone di ricerca, lo psicologo Marvin Zuckerman, dell'Università del Delaware, ha trascorso cinque decenni (dagli anni '60 agli anni 2000) studiando la ricerca di sensazioni, ovvero la propensione a correre rischi per acquisire esperienze varie, nuove e intense. E nel 2006 la psicologa Britta Renner, dell'Università di Costanza, ha avviato lo studio della curiosità sociale, ovvero l’interesse delle persone nel comprendere come gli altri pensano, sentono e si comportano.
8 tipi di curiosità
La curiosità è un elemento così fondamentale della nostra natura che quasi non ci rendiamo conto di quanto sia pervasiva nelle nostre vite. Pensiamo, però, a quanto tempo passiamo a cercare e consumare informazioni: ascoltando le notizie o la musica, navigando su internet, leggendo libri o riviste, guardando la TV, film e sport, o impegnandoci in altre attività non direttamente alla sopravvivenza di base. E oggi, la nostra insaziabile sete di informazioni alimenta gran parte dell’economia globale.
Tuttavia, non tutte le forme di curiosità sono uguali.
Mentre il desiderio di apprendere e comprendere è alla radice di ogni forma di curiosità, esistono numerose varianti di curiosità: i ricercatori Grotelueschen, Friedman e Duckworth ne hanno identificati otto diversi tipi.
/ Curiosità diversiva
Ci spinge a cercare nuove opportunità e a visitare luoghi sconosciuti. Questo tipo di curiosità è spesso stimolato dal desiderio di novità e varietà.
Esempi: provare una nuova attività, viaggiare o approfondire un argomento non correlato ai propri interessi abituali.
// Curiosità epistemica
È ciò che ci spinge a porre domande e cercare risposte, acquisire informazioni, e spesso si concentra su un particolare argomento o campo di studio.
Esempi: fare domande su come funziona qualcosa o cercare informazioni su un tema specifico.
/// Curiosità Emotiva
Ci spinge a chiedere informazioni sui pensieri o le esperienze di un’altra persona, spesso mira a scoprire più dettagli sull’interlocutore e creare una connessione.
Esempi: desiderio di conoscere meglio i sentimenti e i pensieri di qualcuno, fare domande sulle sue esperienze di vita o cercare di comprendere il suo punto di vista.
//// Curiosità estetica
Riguarda il desiderio di osservare la bellezza e l’estetica: è ciò che ci ispira ad apprezzare le arti e a cercare esperienze piacevoli.
Esempi: ammirare un’opera d’arte, ricercare esperienze nuove e affascinanti o contemplare la bellezza della natura.
///// Curiosità religiosa
È ciò che ci fa riflettere su questioni di fede e a cercare esperienze spirituali.
Esempi: studio della storia e degli insegnamenti di una particolare religione, fare domande su altre fedi e credenze e sperimentare pratiche e incontri spirituali.
////// Curiosità pratica
Nasce dal desiderio di acquisire nuove abilità o conoscenze utili nella vita quotidiana, è ciò che alimenta il problem-solving.
Esempi: cercare informazioni su come riparare qualcosa o esaminare le migliori opzioni di prodotti o servizi per soddisfare un determinato bisogno.
/////// Curiosità esistenziale
Nasce dall’interesse per il significato e lo scopo della vita. Spesso si concentra sulle “grandi domande” riguardanti l’esistenza e la natura della realtà
Esempi: cercare spiegazioni sulla natura della realtà o approfondire idee filosofiche e spirituali.
//////// Curiosità sensoriale
L’impulso a sperimentare e comprendere i sensi — come gusto, tatto e olfatto — alimenta la curiosità sensoriale.
Esempi: esplorare nuovi sapori e cucine, utilizzare i sensi per scoprire nuovi ambienti e sperimentare esperienze sensoriali (come la deprivazione sensoriale o la realtà virtuale).
Per questa puntata è tutto, ci rivediamo in inbox sabato 7 marzo.
Alla prossima,
Erica
Mi chiamo Erica Cariello e lavoro come Creative Strategist indipendente. Collaboro con brand e agenzie creative allo sviluppo di campagne pubblicitarie e progetti multi-canale, per trovare nuove prospettive e dare la giusta direzione a idee e parole.